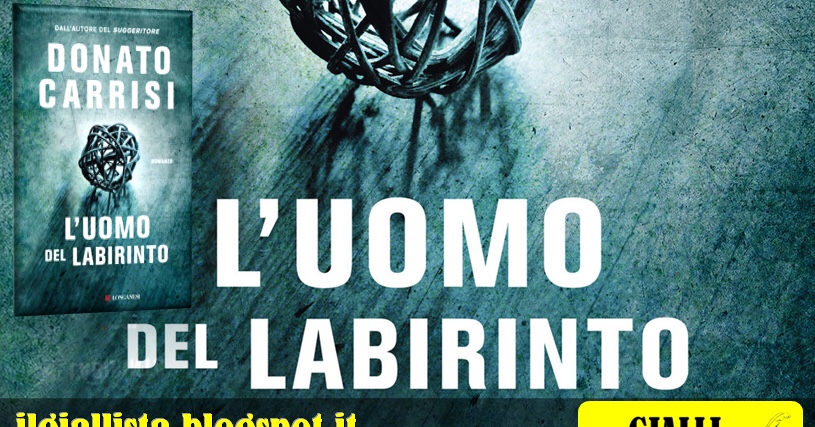Immagino un po’ il rammarico di Rosella Postorino quando ha scoperto che la donna che voleva intervistare non c’era più.
La donna che voleva intervistare si chiamava Margot Wölk e nel 2013 aveva rivelato alla stampa tedesca il suo segreto, di avere lavorato per il Führer.
La notizia, molto particolare, era stata ripresa anche dalla stampa italiana ed aveva incuriosito la scrittrice.
Purtroppo il tempo non ha giocato a suo favore e la Postorino è stata costretta a lavorare di fantasia ricostruendo una storia attorno all’esistenza reale di un gruppo di assaggiatrici, donne con la missione di pre-gustare le pietanze servite ad Hitler, che viveva nella fobia di essere avvelenato.
Immagino il suo rammarico dico, perché appena dopo aver letto la prima pagina del libro ho iniziato a ripensare alle mie nonne e a quei racconti del tempo della guerra, ai quali prestavo orecchio dissimulando noia e che invece avrei fatto meglio ad ascoltare.
Me ne ricordo uno in particolare: la nonna materna raccontava che nell’estate del ‘44, a pochi giorni dal termine della sua prima gravidanza, con un pancione così, riceveva la visita di due soldati fascisti sulle tracce di un partigiano, e le puntavano contro i fucili, contro il suo pancione così.
Del suo racconto conservo il dettaglio del sudore: sudava per la canicola, sudava per la gravidanza, sudava per la paura.
Quell’episodio l’aveva segnata, per quel fatto giustificava ogni comportamento di suo figlio, mio zio, nato ‘in tempo de guera’.
Il ritardo nella ricerca a mio avviso è stato provvidenziale: non potendo intervistare Margot Wölk l’autrice ha dato vita a personaggi inventati e reso un quadro molto suggestivo delle vicende.
Margot Wölk diventa Rosa Sauer (forse alter ego di Rosella, nome di battesimo della Postorino) e narra in prima persona ciò che ha vissuto: come ha lasciato Berlino per arrivare al confine con la Polonia, come ha perso i genitori, come è stata arruolata per la missione di assaggiatrice, e come l’ha svolta.
Oltre alla descrizione delle attività quotidiane il romanzo si dipana nel racconto di molti altri aspetti: il rapporto con il cibo, i legami di amicizia, i soprusi, la vita che va oltre la guerra.
Lo stile è fluente, pur essendo ricco di dettagli nelle descrizioni, molto realistiche.
Il racconto passa dai pensieri alla realtà, dalle ipotesi al concreto, dal passato al presente e rende il lettore compartecipe delle situazioni.
Molte le riflessioni che la lettura mi ha indotto: l’ambivalenza del cibo, nutrimento ma possibile veleno mortale; l’ambivalenza dell’atto sessuale, fonte di senso di colpa quando avviene al di fuori degli schemi e pulsione vitale al tempo stesso; la rivoluzione che è stata introdotta nella società dall’uso dei contraccettivi; i meccanismi dell’odio e della prevaricazione che nonostante sia trascorso quasi un secolo non hanno subito mutazioni; i rapporti di amicizia al femminile, così controversi e così intensi.
La figura di Hitler c’è ma non si vede: nonostante venga descritto da lontano, avvolto da un alone di mistero, che nemmeno le SS arrivano tutte ad incontrarlo, alla fine anche lui è un tubo digerente; quando ingoierà quegli stessi succulenti piatti preparati da Briciola, il cuoco, se mangia gli asparagi la sua urina avrà lo stesso odore caratteristico di chi il piatto l’ha mangiato un’ora prima di lui.
Nessuna indulgenza nei suoi confronti: viene descritto come un pazzo, un maniaco ossessivo compulsivo, uno che, al di là delle crudeltà della guerra, manda i suoi soldati a ripopolare il bosco di rane, dopo che erano state uccise assieme alle zanzare, perché senza il loro canto non riesce ad addormentarsi.
Rosa ha anche un marito, Gregor; avrebbe un marito, perché lui l’ha lasciata con i suoceri ad attenderlo, mentre andava al fronte a combattere; aveva un marito, perché dal fronte viene annunciato come disperso. Avrà un marito, ma… non voglio anticipare troppo i contenuti e guastare la lettura.
Rosa ha un amante, se lo si può considerare tale in contumacia del marito.
Un amante che forse non la ama, o a cui non è concesso di amarla, ma che, non sappiamo a costo di quali rischi, le salva la vita.
L’autrice descrive l’uno e l’altro rapporto senza retorica nè luoghi comuni, rendendo perfettamente il dilemma nel lettore.
Viene affrontato il tema della maternità, della procreazione consapevole e responsabile, e anche di quella fortuita.
Il gruppo di donne, inizialmente estranee l’una all’altra, e per alcuni aspetti in contrasto tra loro, a poco a poco diventa un nucleo di amiche, seppure con affinità distinte.
Sul pulmino che le conduce al lavoro sembra di sedere accanto ora a Ulla, ora a Beate, ad Heike, a Leni, ad Elfriede e ad Augustine; come se la loro cattività costringesse anche noi ad approfondirne la conoscenza.
Le assaggiatrici non sono tutte convinte della bontà delle idee del Fuhrer: solo un paio di loro sostengono la causa tedesca.
I capitoli conclusivi del romanzo sono magistrali: su un treno che, come quello di de Gregori, non fa più fermate neanche per pisciare, Rosa ancora una volta si trova a stringere nuove amicizie, a condividere i suoi viveri, a consolare un pianto. Fino ad arrivare a casa, fondendo passato e presente in modo superlativo.
Pur descrivendo fatti accaduti quasi un secolo fa, alcuni di essi mi hanno richiamato potenti analogie con episodi di cronaca attuali, come lo stupro nei casi in cui viene sollevato il dubbio di un possibile consenso da parte della vittima; o come la condizione dei migranti.
Al contrario di un altro romanzo che racconta vicende accadute nello stesso periodo storico, e che non sono mai riuscita a terminare (‘La banalità del male’), ho divorato questo in pochi giorni: ha saputo raccontare la guerra in tutta la sua crudeltà senza creare orrore e raccapriccio, appigliandosi a ciò che di positivo vive sopito nel corso del conflitto.
Nella caserma di Krausendorf rischiavamo di morire ogni giorno – ma non più di chiunque sia vivo. Su questo aveva ragione mia madre, pensavo mentre il radicchio mi croccava tra i denti, e il cavolfiore impregnava le pareti del suo odore domestico, rassicurante.